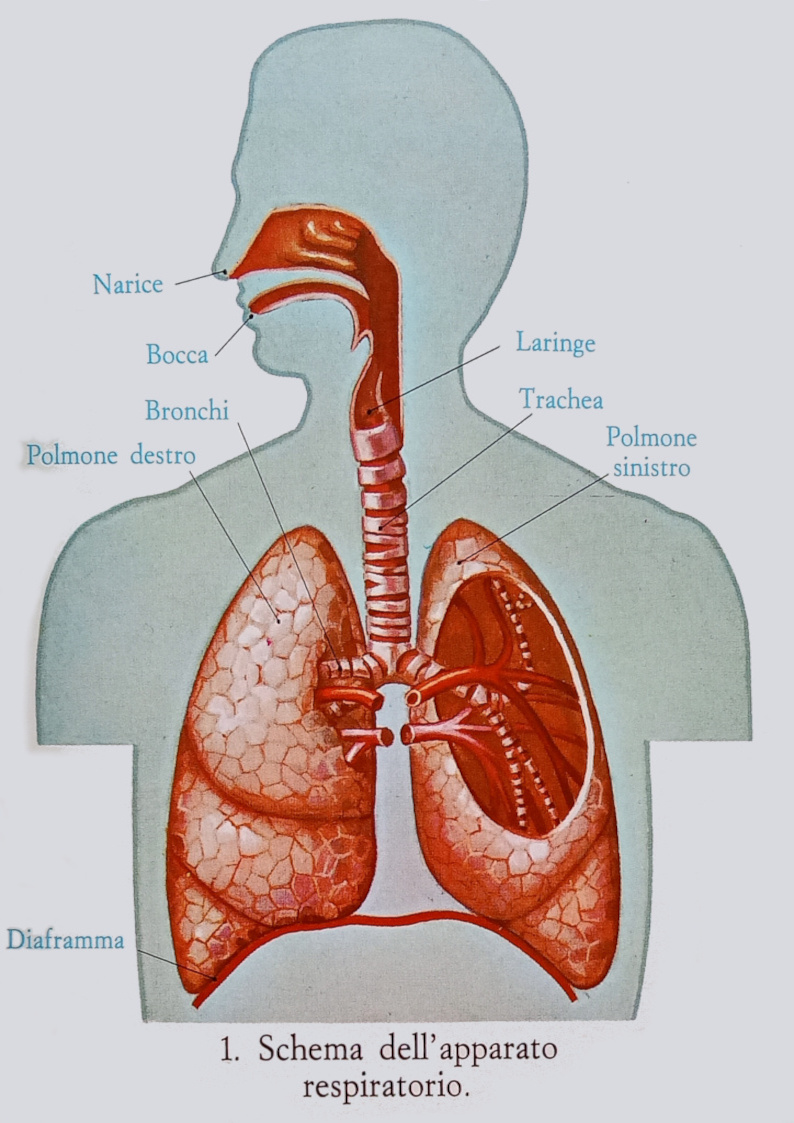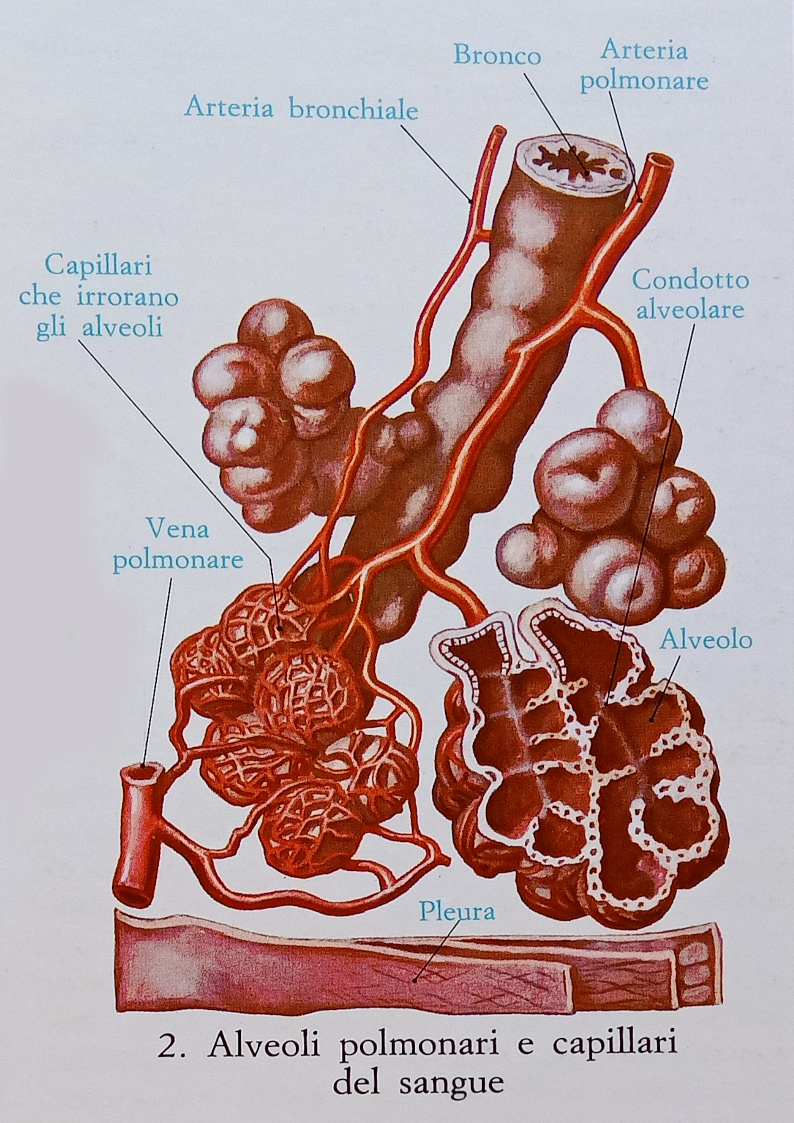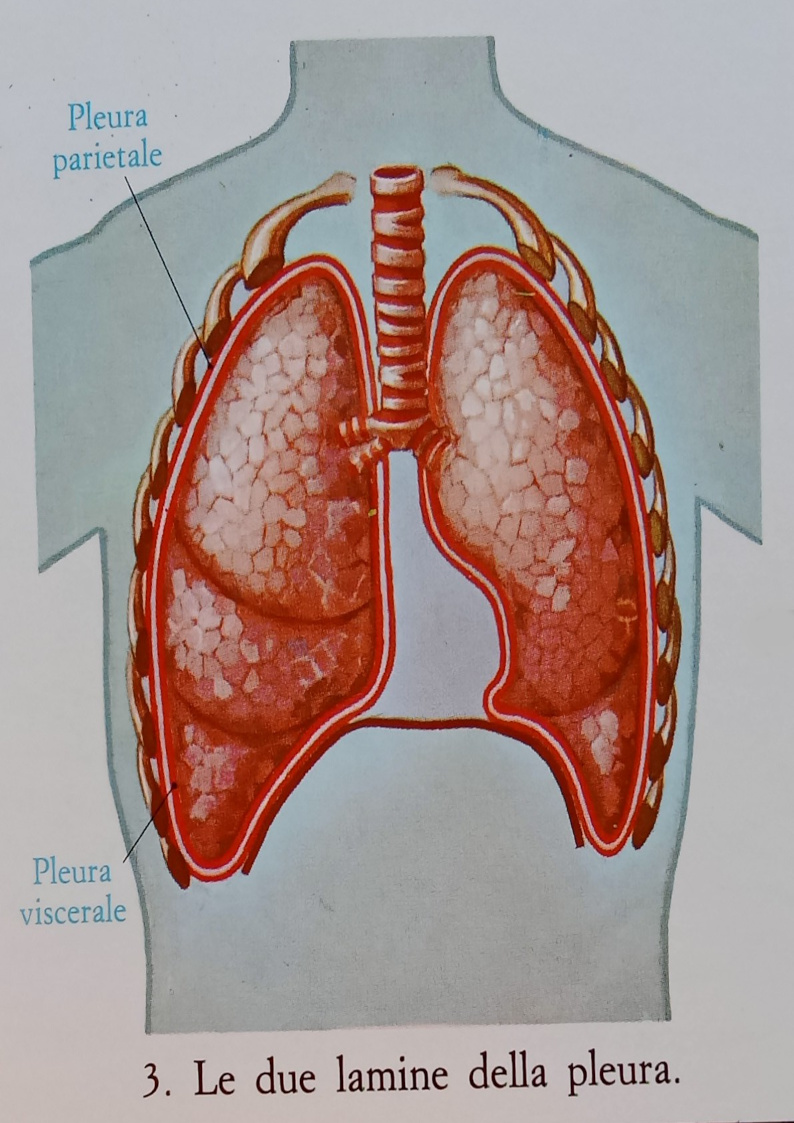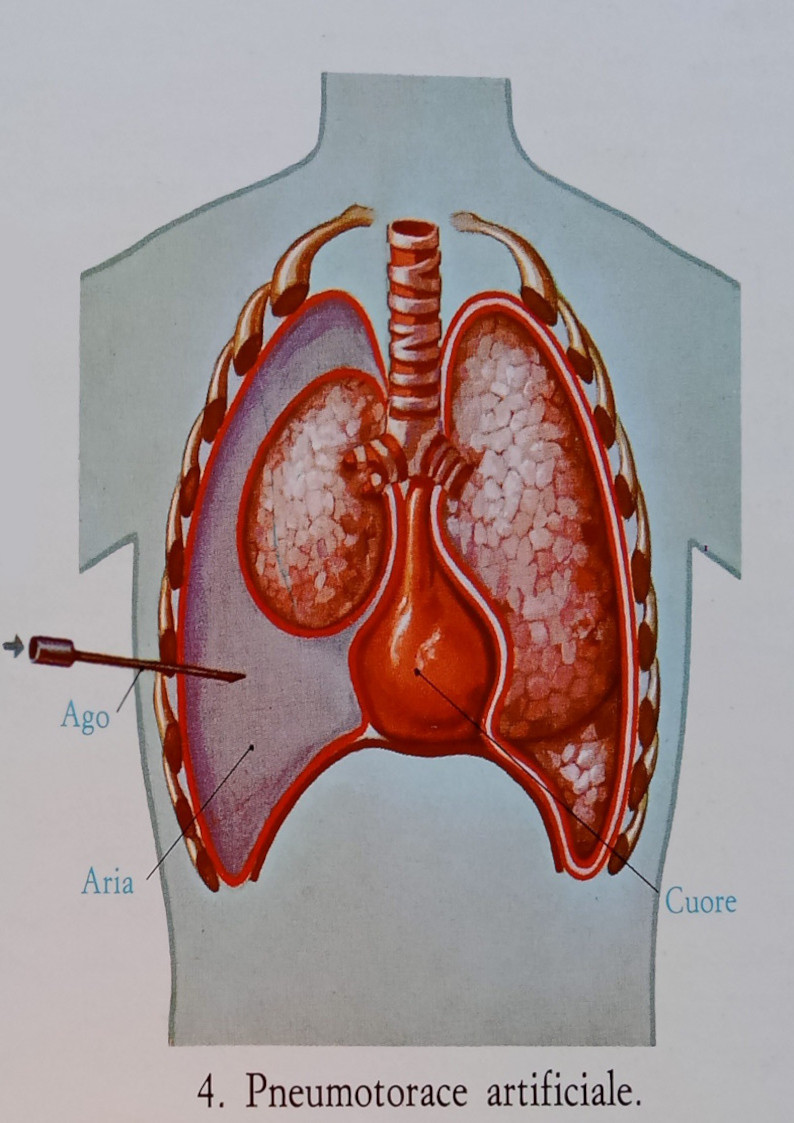APPARATO RESPIRATORIO
La Respirazione
La respirazione, nel senso più ampio, comprende i seguenti
processi
:
- passaggio dell'aria attraverso le vie respiratorie sino agli alveoli polmonari
- passaggio al sangue dell' ossigeno
- trasporto dell'ossigeno attraverso il sangue e sua distribuzione a tutto l'organismo
- utilizzazione dell' ossigeno (O2) da parte delle cellule
- produzione cellulare di anidride carbonica
- trasporto attraverso il sangue dell'anidride carbonica
- passaggio dell'anidride carbonica dal sangue agli alveoli polmonari
- espulsione dell'aria dai polmoni
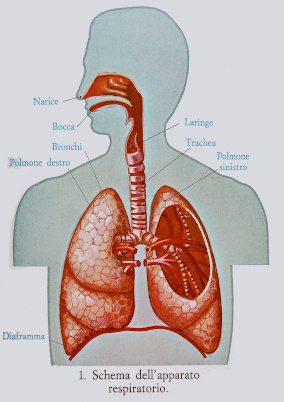
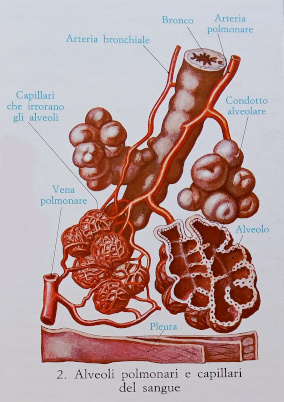
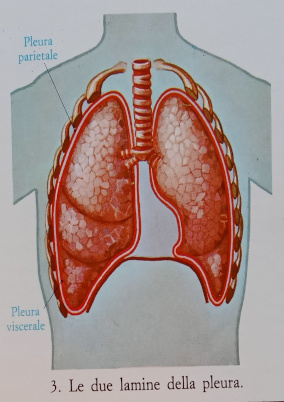
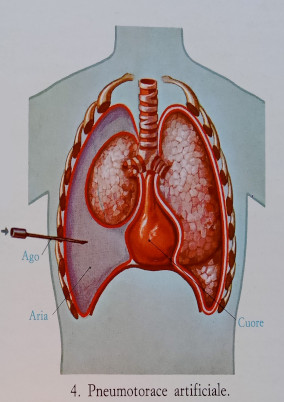
I processi di utilizzazione dell'ossigeno e di produzione di anidride carbonica
costituiscono la
respirazione cellulare
(qui non esaminati).
Organi fondamentali
dell'apparato respiratorio sono i
polmoni
e le
vie respiratorie
(→ 1). Queste partono dal
naso
e sono costituite da una serie di condotti che, dopo essersi abbondantemente ramificati, terminano negli
alveoli polmonari
, detti anche "celle respiratorie", poiché in essi avviene lo
scambio gassoso
tra il
sangue
e l'aria respirata. La loro superficie (→ 2) è vascolarizzata da numerosissimi
capillari
provenienti dall'arteria e dalle vene polmonari.
L'
aria
in arrivo agli
alveoli polmonari
deve essere sprovvista di
particelle in sospensione
ed avere
temperatura e umidità adeguate e composizione chimica costante
. In caso contrario si altererebbe lo stato del mezzo interno.
Nel tortuoso tragitto percorso per giungere negli alveoli polmonari, l'aria si
libera in effetti delle impurità
, si
umidifica e si riscalda
, mentre i
movimenti respiratori
contribuiscono a compensarne qualsiasi anomalia.
Le
vie respiratorie
partono, come si è detto, dal
naso
, le cui aperture esterne, le
narici
, possono
dilatarsi e restringersi
in virtù degli annessi muscoli mimici (muscoli trasversali delle narici).
Nella
cavità nasale
, la
mucosa respiratoria
depura l'aria
, eliminando il pulviscolo atmosferico mediante il
movimento delle ciglia
di cui sono fornite le cellule cilindriche che la costituiscono. Inoltre, essendo riccamente
vascolarizzata
, essa fa sì che l'aria inspirata sia
riscaldata ad una temperatura vicina a quella corporea
. Attraverso le
coane
il naso comunica con la
faringe
, organo comune sia all'apparato respiratorio sia a quello digerente.
Alla faringe seguono la
laringe e la trachea
.
La prima
è un organo dotato di
motilità
: può dunque compiere
movimenti, per lo più in senso verticale
, dovuti alla respirazione, alla deglutizione, all'estensione e alla flessione del collo.
La seconda
, costituita da una serie di
16-20 anelli cartilaginosi sovrapposti ma incompleti
, è tappezzata internamente da
tessuto epiteliale ciliato
.
La trachea
, all'altezza della quarta vertebra toracica, si
biforca
nei due grossi
bronchi, o bronchi extrapolmonari
, che, attraverso un avvallamento detto
ilo
, penetrano nel corrispondente polmone e prendono a suddividersi in numerose ramificazioni, il cui complesso costituisce l'
albero bronchiale
.
La
struttura dei grossi bronchi
è simile a quella della trachea poiché formati anch'essi da
anelli cartilaginei
immersi nel tessuto connettivo.
Nei
bronchi intrapolmonari
la porzione cartilaginea è costituita da
placche
, disposte regolarmente su tutta la superficie del bronco, che
diminuiscono di grandezza e di numero
a mano a mano che il calibro dei bronchi si riduce, finché
scompaiono
nei bronchi che hanno calibro inferiore al millimetro. Anche la mucosa si
modifica
nei piccoli bronchi; qui, infatti, anziché da epitelio pluristratificato, essa è costituita da
epitelio ciliato cilindrico monostratificato
.
I bronchi penetrano nei
polmoni
: sono, questi, due organi che occupano la
cavità toracica
delimitando uno spazio centrale, il
mediastino
, in cui ha sede il cuore.
I polmoni sono ricoperti da una
membrana sierosa a doppia parete
di cui una, la
pleura viscerale
, aderisce alla superficie polmonare e l'altra, la
pleura parietale
, si dispone sulla superficie interna della cavità toracica (→ 3). Fra le due pareti si trova un sottilissimo strato di
liquido, il liquido pleurico
, che
mantiene lubrificate le pareti
dei foglietti pleurici, facilitando in tal modo i
movimenti di espansione e di contrazione durante la respirazione
. Se, per qualsiasi causa, penetra dell'
aria nella cavità pleurica
, si determina uno
pneumotorace
: di conseguenza si
riduce notevolmente l'attività polmonare
per la diminuzione di volume e di pressione del polmone stesso.
Si deve comunque rilevare che se lo
pneumotorace
è relativo a un solo lato può essere ben tollerato; anzi nella
tubercolosi
lo si
provoca come terapia
(
pneumotorace artificiale
, (→ 4), affinché un polmone si affatichi il meno possibile.
Fisiologia della respirazione
I
polmoni sono organi molto elastici
, capaci quindi di
espandersi e contrarsi
. Al momento dell'espansione, nei polmoni viene
immessa aria
; nella fase di compressione, l'aria viene
espulsa
. L'insieme di questi due movimenti prende il nome di
atto respiratorio
e questo è suddiviso in due fasi: l'
inspirazione e l'espirazione
.
Durante l'
inspirazione
si ha un
aumento di volume della capacità toracica
dovuto alla
contrazione dei muscoli inspiratori
. Tra questi, forse il più importante, è il
diaframma
, che, contraendosi, si
abbassa e così, provocando un aumento della capacità toracica e una diminuzione della pressione nella stessa
, permette l'
ingresso dell'aria nei polmoni
(→ 1). I
muscoli intercostali esterni
, contraendosi, provocano un innalzamento e uno spostamento in fuori dello sterno e delle costole, il che permette un aumento dei diametri anteroposteriore e trasverso del torace.
Da notare che nella
donna
i movimenti delle costole hanno importanza maggiore nella respirazione che nell'uomo, in cui assume maggior rilievo la
funzione del diaframma
. Si usa dire che la respirazione nelle donne è prevalentemente
costale
, mentre nell'uomo è di tipo
diaframmatico o addominale
.
La fase espiratoria
è di norma
passiva
e determinata dal
rilasciamento dei muscoli prima contratti
; in seguito a ciò la capacità toracica
diminuisce e l'aria può fuoriuscire dai polmoni
.
La quantità di aria immessa ed emessa durante un atto respiratorio normale è di circa
500 cm³ (aria corrente)
, ma essa può aumentare notevolmente in particolari condizioni. Così, in un'inspirazione forzata può essere introdotto un volume di aria di circa
2000-3000 cm³ (riserva inspiratoria)
, mentre in un'espirazione forzata può essere emesso un volume di aria di circa
1000 cm³ (riserva espiratoria)
. La somma dei volumi di aria corrente sia della riserva inspiratoria sia della riserva espiratoria viene detta
capacità vitale dei polmoni
ed è di circa
4000-4500 cm³
.
In un individuo adulto normale gli
atti respiratori sono circa 16 al minuto
; diminuiscono di poco nella donna e sono molto numerosi nel neonato che ne presenta circa
60-70
. Il numero
aumenta quando si compie un lavoro
ed è più elevato in individui a sistema muscolare sviluppato, per esempio negli atleti, meno elevato in individui obesi.
Il controllo dell'attività respiratoria
è esercitato nel
centro respiratorio
situato nel
bulbo
(→ 4). Da questo hanno origine
impulsi nervosi
che si portano alle corna anteriori del midollo spinale e quindi, mediante i nervi spinali, arrivano ai
muscoli inspiratori
e ne provocano la contrazione in seguito alla quale si ha l'inspirazione.
Si deve osservare che solo in questa fase il
centro bulbare entra in azione
, mentre l'
espirazione
è provocata semplicemente dalla diminuzione del volume della gabbia toracica.
Il
centro respiratorio
è influenzato dallo
stato di distensione o di retrazione del polmone
. Durante l'espirazione, lo stato di retrazione dei polmoni genera
impulsi nervosi che eccitano il centro respiratorio
dove hanno origine gli impulsi che provocano l'inspirazione. Il centro respiratorio è
regolato anche dalla quantità di anidride carbonica presente nel sangue
. Nel sangue deve esistere una
determinata concentrazione di anidride carbonica
perché il centro respiratorio possa funzionare bene. Un
aumento della concentrazione di anidride carbonica nel sangue
, dovuta ad un aumento della sua concentrazione nell'aria, provoca un
eccitamento del centro respiratorio
, con conseguente
aumento della frequenza del respiro
.
Una concentrazione dell'anidride carbonica nell'aria, superiore al 9%
,
inibisce però il centro respiratorio
e provoca disturbi alla respirazione.
Maggiore importanza
hanno i
recettori sensibili alla diminuzione dell'ossigeno nel sangue
che
stimolano, anche per via riflessa, il centro respiratorio
.
Un importante meccanismo
è quello che in ciascuna inspirazione
limita il grado di espansione del torace
. Vi sono
recettori sensibili alla pressione nei polmoni
, che si scaricano a mano a mano che progredisce il movimento inspiratorio. Questi
impulsi giungono, per mezzo dei nervi vaghi, al centro respiratorio e lo inibiscono
: viene così
interrotta l'inspirazione
e sopravviene passivamente l'espirazione.
Si deve comunque rilevare che se lo
pneumotorace
è relativo a un solo lato può essere ben tollerato; anzi nella
tubercolosi
lo si
provoca come terapia
(
pneumotorace artificiale
, (→ 4), affinché un polmone si affatichi il meno possibile.
BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.