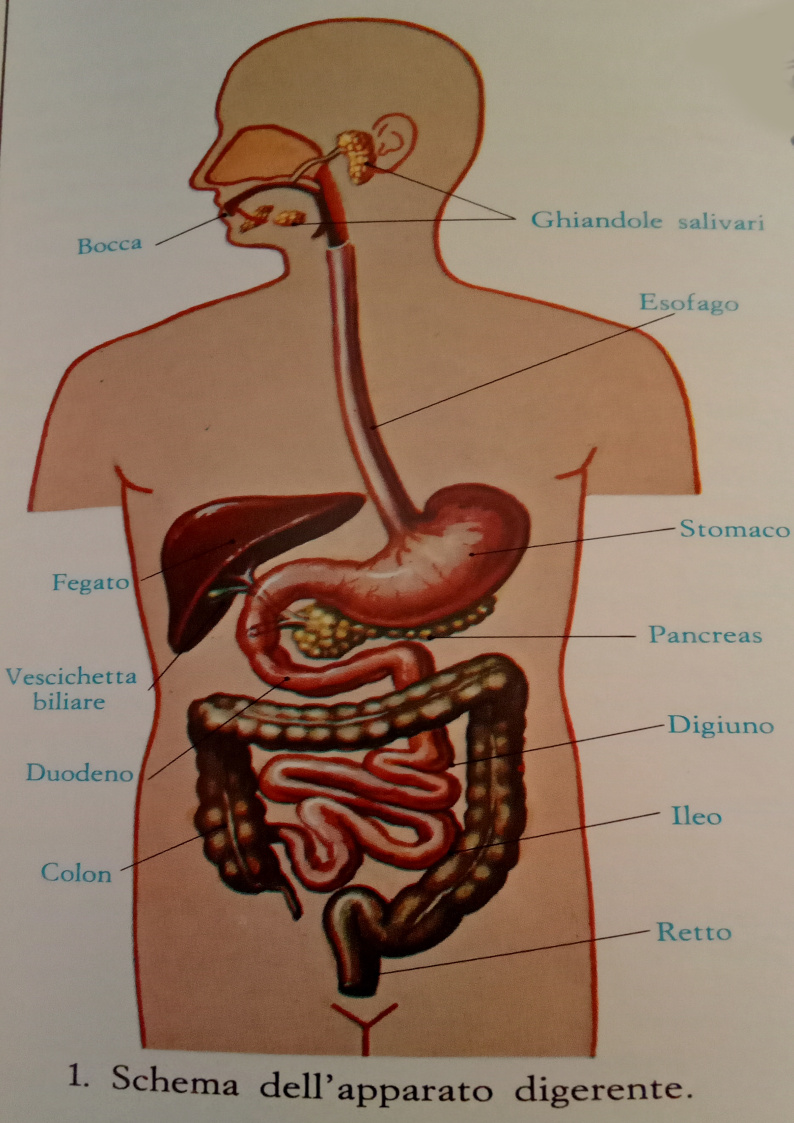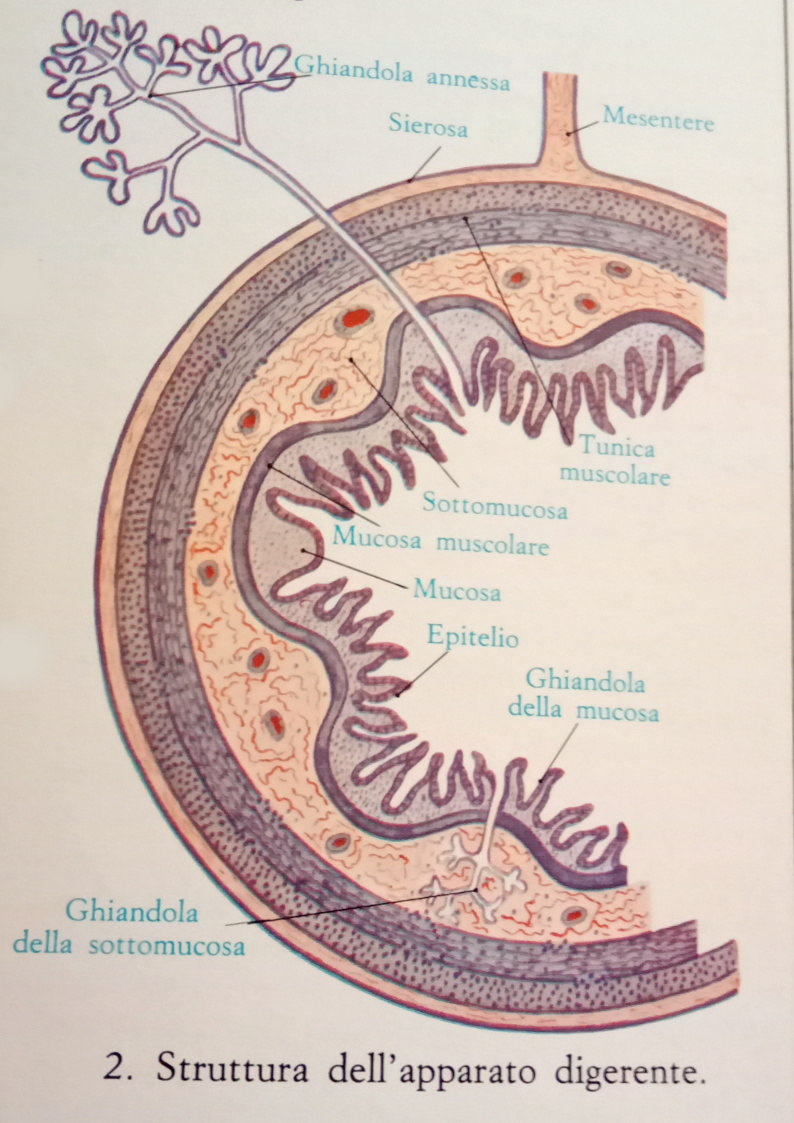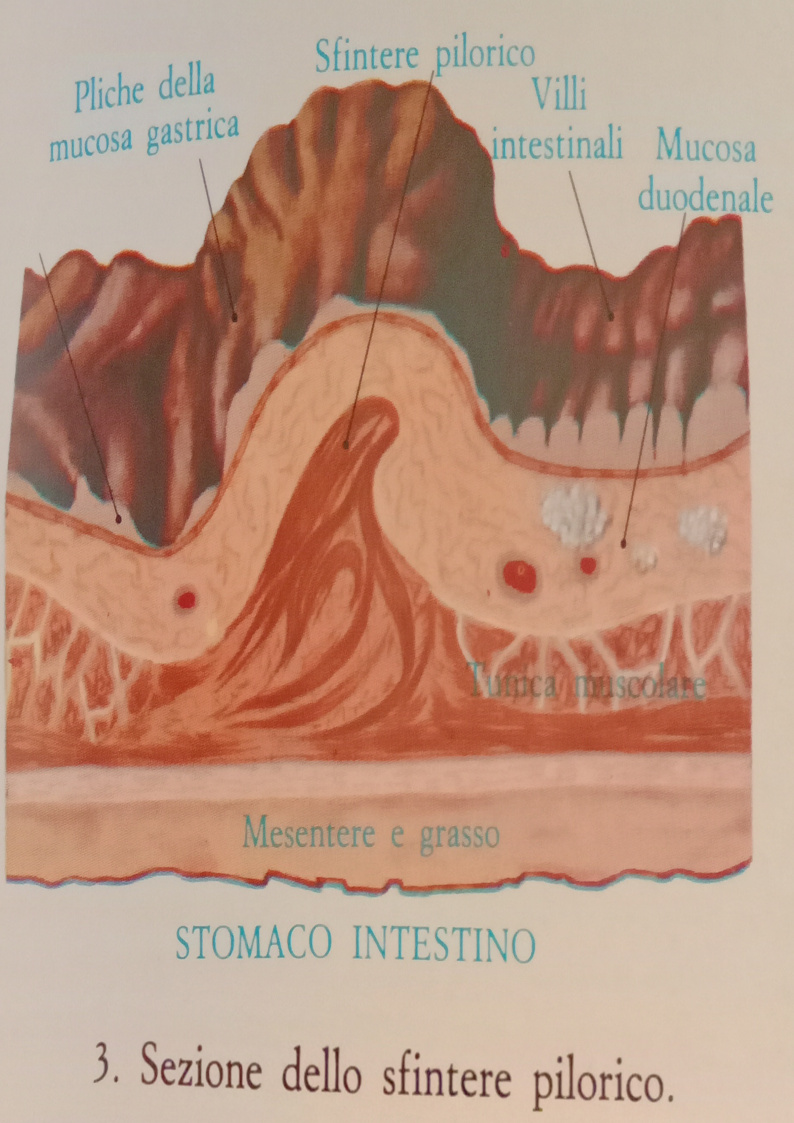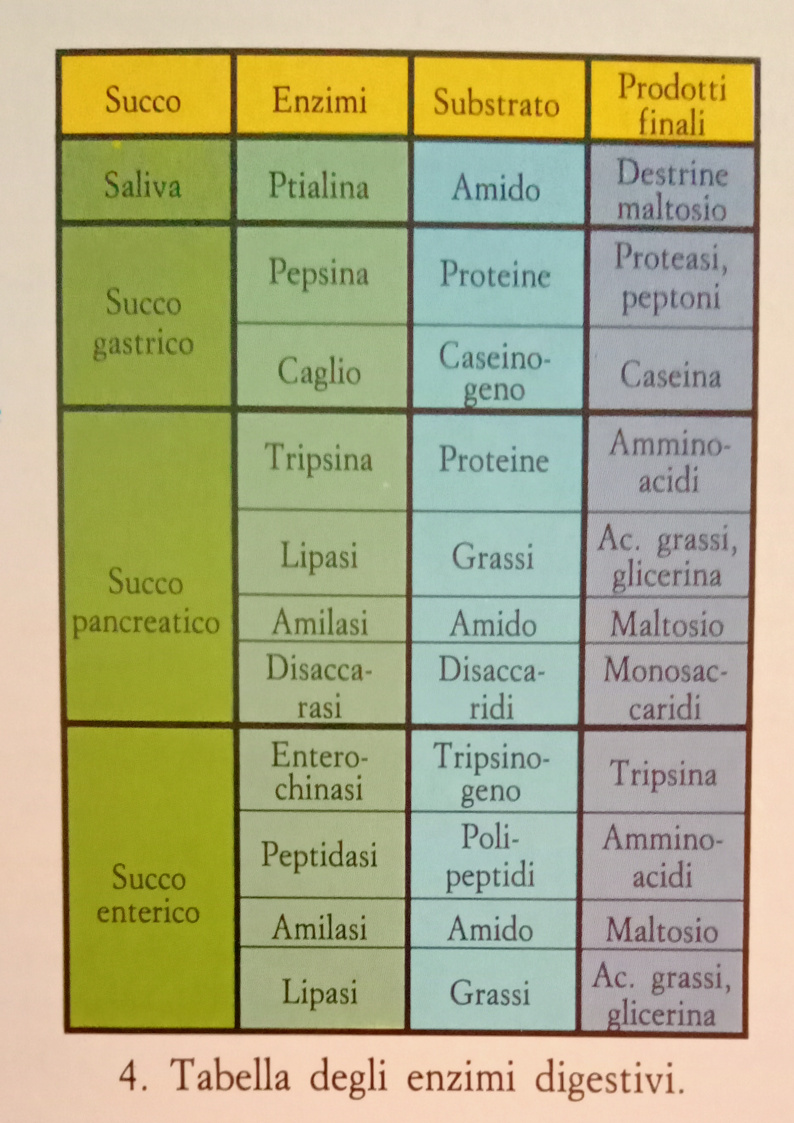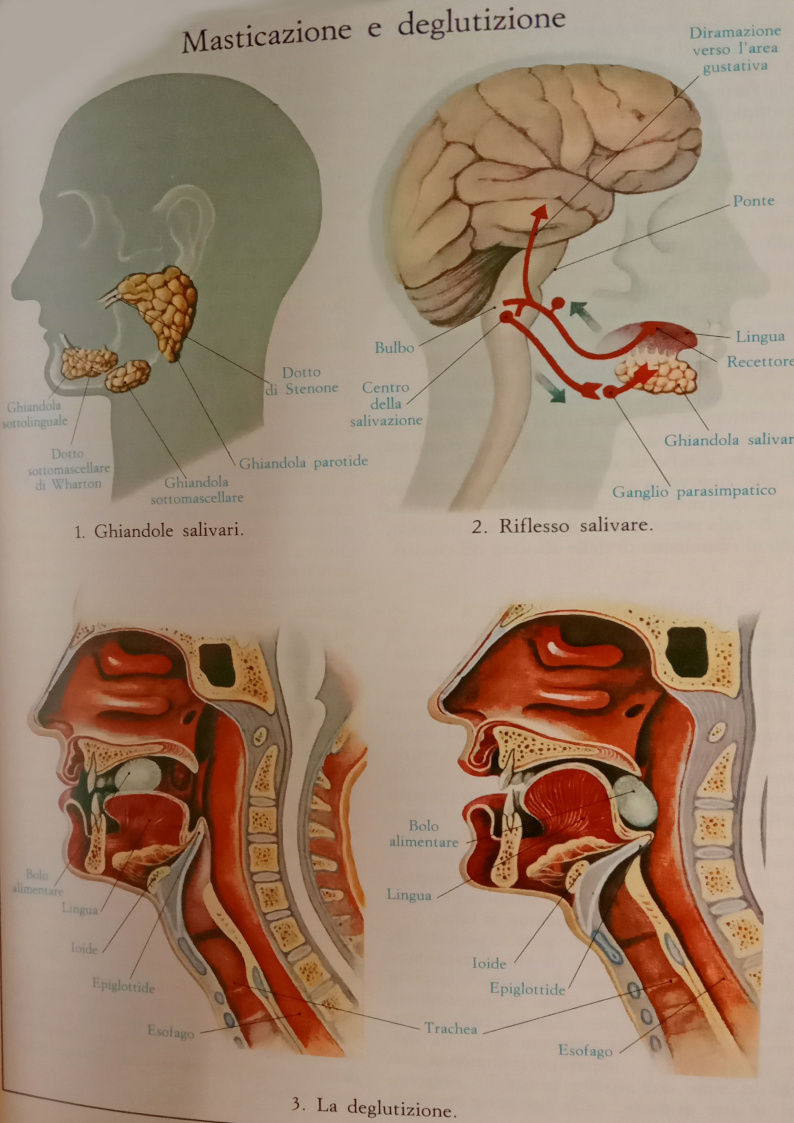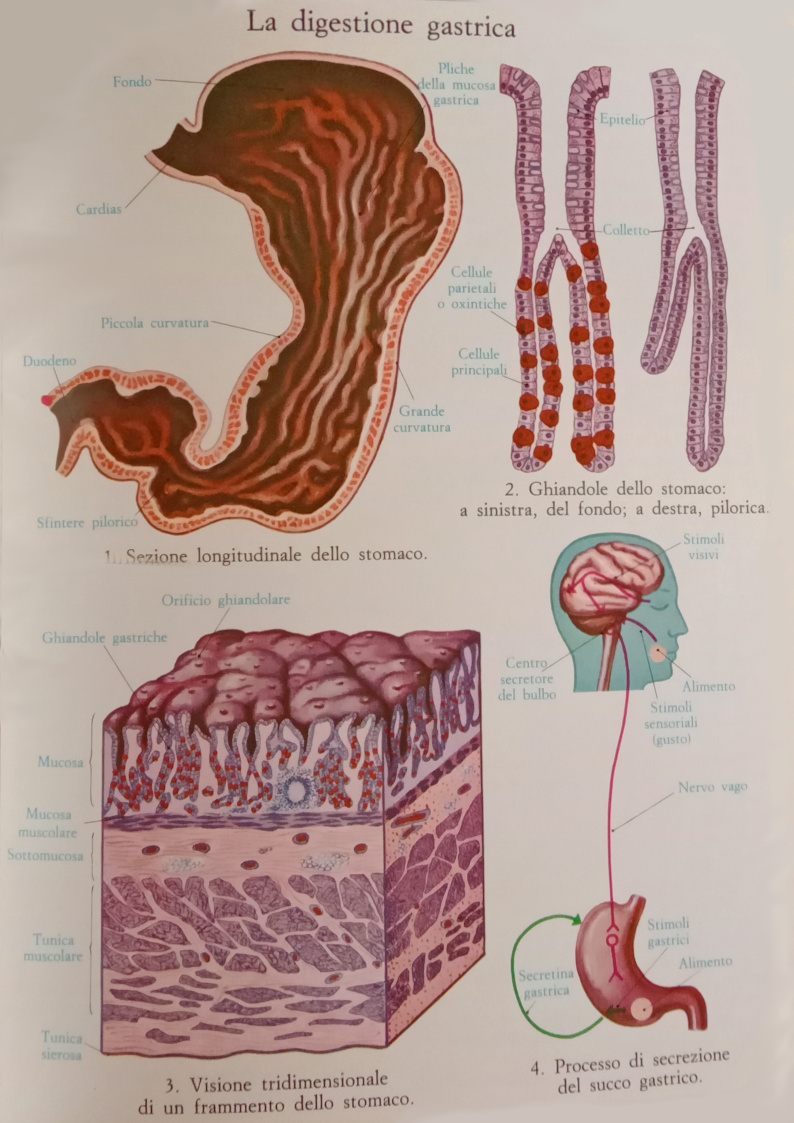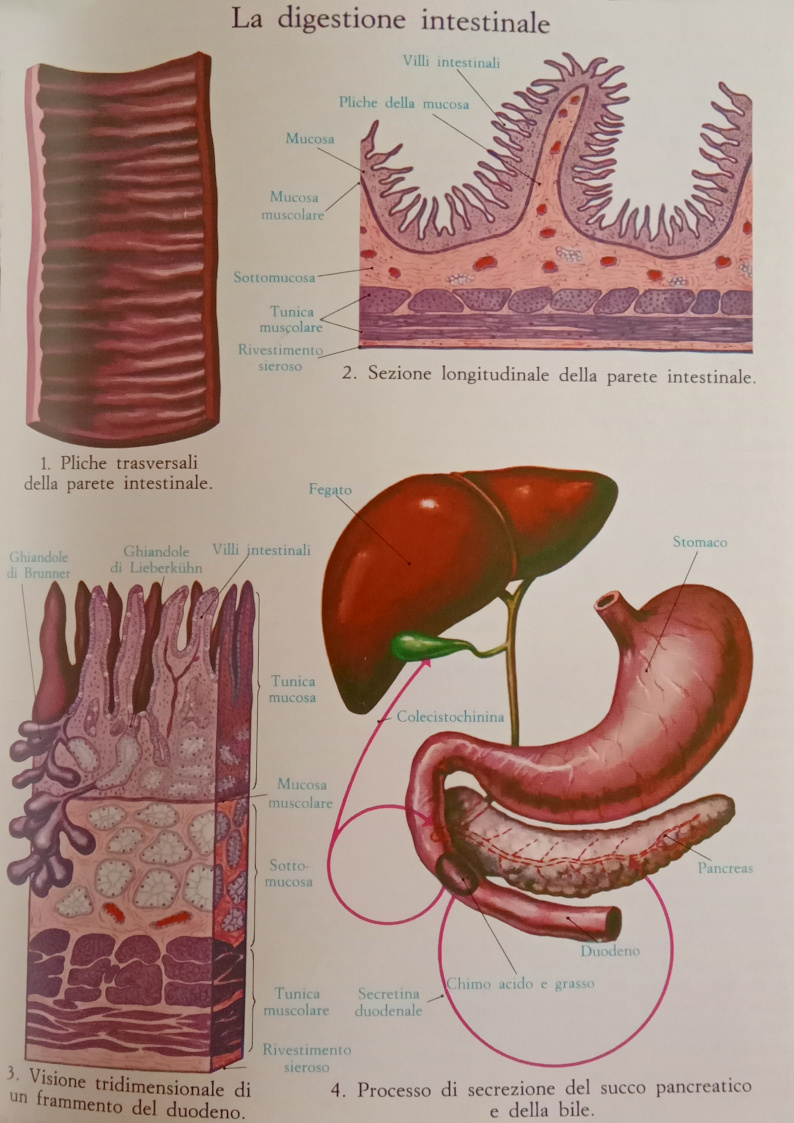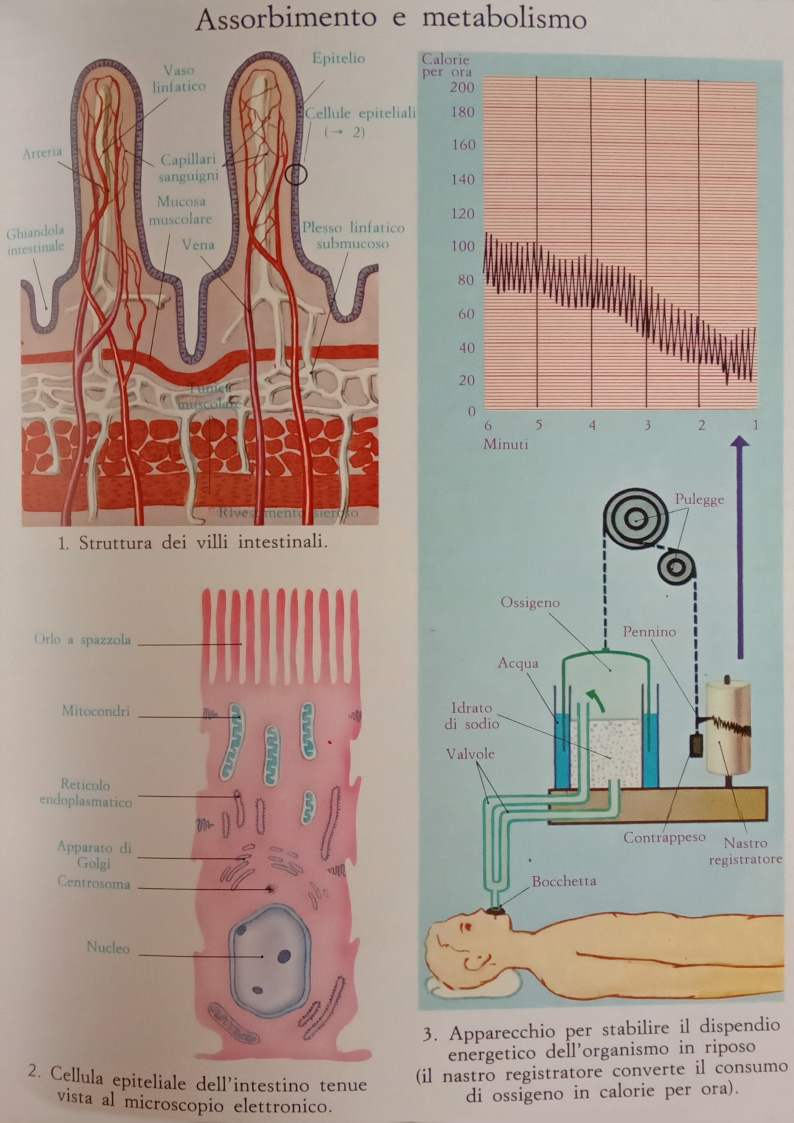APPARATO DIGERENTE
Introduzione digestione
Necessaria all'uomo per l'accrescimento corporeo, per rinnovare le cellule che via via si distruggono e reintegrare le energie che servono ai vari organi a funzionare, la
nutrizione
comprende una successione di eventi:
Il primo, detto
alimentazione
consiste nell'ingestione dei cibi.
Per essere assimilati e rispondere a tali funzioni, i cibi devono subire una serie di profonde trasformazioni che nel loro complesso costituiscono la
digestione
.
Dette trasformazioni avvengono nel
tubo digerente
, nel quale vari
organi ghiandolari
, tramite condotti di connessione o superficie, introducono alcune sostanze chimiche aventi il compito di trasformare gli alimenti ingeriti sino a renderli assorbibili.
La digestione è infatti un processo di continua
semplificazione chimica
degli alimenti ingeriti.
L'apparato digerente può essere paragonato ad un lungo
tubo continuo
, in cui si distinguono alcuni tratti, diversi per lunghezza, forma e volume (→ 1).
Il primo tratto è rappresentato dalla
bocca
, delimitata anteriormente dalle
labbra
attraverso le quali comunica con l'esterno.
Posteriormente, attraverso l'
istmo delle fauci
, la bocca comunica con la
faringe
situata all'incrocio tra le vie dell'apparato digerente e quelle dell'apparato respiratorio.
Dalla faringe si passa nell'esofago.
Anch'esso di forma tubulare, l'
esofago
congiunge la faringe con lo
stomaco
, che costituisce la
parte più dilatata
dell'intero apparato digerente.
La forma di questo può variare in rapporto alle caratteristiche di ciascun individuo (la si è spesso paragonata a una cornamusa).
Attraverso lo
sfintere pilorico (3)
, costituito da
fibre muscolari circolari
che si addensano maggiormente in questa zona, lo stomaco entra in comunicazione con l'
intestino
.
L'intestino è distinto in due tratti principali: il
tenue
, lungo circa 6 metri e 80 centimetri, e il crasso
, lungo circa 1 metro e 80 centimetri.
Il tenue è diviso a sua volta in
duodeno
, digiuno,
ileo
.
Nel duodeno versano il loro
secreto
due importanti ghiandole annesse, il
pancreas
e il fegato
, e numerose altre ghiandole.
L'ultimo tratto del tenue, l'
ileo
, comunica per mezzo della
valvola ileo-cecale
con il
crasso
, la cui parte iniziale costituisce il
cieco
.
Questo, proseguendo sul lato destro dell'addome, prende il nome di
colon ascendente
. Al livello della superficie inferiore del fegato, esso si ripiega portandosi sul lato sinistro dell'addome con il nome di
colon trasverso
, a cui segue il
colon discendente
che continua quindi nel
retto
.
Questo si apre all'esterno mediante lo
sfintere anale
.
La superficie interna di tutto l'intestino è formata da
mucosa
che assume nel tenue un aspetto del tutto peculiare per la presenza di formazioni atte ad
alimentarne la superficie
.
Sono le
valvole conniventi
, duplicature della stessa mucosa, e i
villi intestinali
.
L'attività digestiva dell'intestino crasso è poco rilevante, a parte l'importante
funzione
che la
flora microbica
assolve sia nella
sintesi di alcune vitamine
sia nella degradazione di diversi elementi che compongono gli alimenti (ma l'abbondanza di microrganismi in questa regione dell'apparato digerente presenta maggior interesse dal punto di vista della patologia che da quello della fisiologia).
Le
feci
, espulse all'esterno attraverso l'
ano
, sono formate non solo da residui inutili degli alimenti ingeriti, ma anche da materiali procedenti dall'apparato digerente e, principalmente, da
batteri intestinali
.
La masticazione
è il
primo atto della digestione
. Essa consiste in una
suddivisione meccanica
degli alimenti prodotta dai denti, che incidono, dilacerano e triturano gli stessi, mentre i movimenti della lingua e delle guance concorrono a rimescolare, nel cavo orale, il cibo già preparato dall'azione della saliva.
L'atto masticatorio, che si compie facendo combaciare le due arcate dentarie, è dominato dai
centri che si trovano nella corteccia temporale e nel bulbo
e che mettono in azione i muscoli (masseteri, temporali, pterigoideo, interno ed esterno, e muscoli abbassatori), i quali consentono i movimenti di elevazione e di abbassamento, oltre che la demolizione di un alimento nelle sue parti costitutive.
La digestione comincia nel cavo orale ad opera degli
enzimi
che, mediante azioni chimiche specifiche, fanno sì che dai cibi assunti si liberino i principi assimilabili a scopi nutritivi.
Ciò significa che gli enzimi sono dei
catalizzatori
, che favoriscono una reazione chimica e si ritrovano immutati al termine della reazione.
Un enzima si inserisce in una specifica molecola, la
spezza
e quindi se ne distacca mantenendo la proprietà di ripetere, possiamo dire indefinitamente, l'operazione.
Gli enzimi si distruggono soltanto con l'uso o per avvelenamento.
Come si è detto, ogni enzima ha un campo d'azione
limitato e specifico
: per es., la pepsina del succo gastrico scinde le proteine, lasciando inalterati i grassi e i carboidrati; il caglio opera esclusivamente la coagulazione della caseina del latte; la maltasi scinde il maltosio, ma non il saccarosio, ecc.
Fino dal XVIII secolo,
Lazzaro Spallanzani
aveva intuito l'importanza di queste sostanze, quando stabiliva, con i suoi esperimenti, che le trasformazioni chimiche che si verificano negli alimenti durante la digestione avvengono per opera dei
succhi gastrici
contenenti, come si scoprì in seguito, gli enzimi.
Al cavo orale sono annesse numerose
ghiandole
(→1), rappresentate perlopiù dalle
parotidi, dalle sottolinguali e dalle sottomascellari
.
Esse secernono la
saliva
, costituita essenzialmente di acqua (98,7%), da sostanze inorganiche (0,8%) e da sostanze organiche (0,5%).
Tra le sostanze inorganiche, i
cloruri
sono gli
attivatori dell'amilasi
;
i
bicarbonati e i fosfati
costituiscono un
sistema tampone
che mantiene il pH salivare vicino alla neutralità.
Tra i costituenti organici, ci sono la
mucina
e numerosi enzimi, il più importante dei quali è la
ptialina
, che
attacca l'amido
, scindendolo idroliticamente fino a destrine e maltosio, e che continua la sua azione finché non viene inattivata, nello stomaco, dall'
acido cloridrico
.
L'azione enzimatica della ptialina si realizza infatti a un
pH approssimativamente neutro
.
L'azione si esplica meglio sull'
amido cotto
, quando i granuli non sono più protetti dall'involucro di cellulosa.
Oltre alla
funzione digestiva
, la saliva favorisce la masticazione, la
formazione del bolo alimentare
, la deglutizione e, per mezzo della mucina, la
lubrificazione dell'esofago
.
Sembra anche che favorisca la
funzione gustativa
e che svolga un'
azione protettiva sui denti
.
Attraverso la
sensazione di sete
, la saliva entra anche nel
meccanismo di regolazione del ricambio idrico
.
La saliva viene prodotta in maniera continua, ma la quantità varia sia in rapporto alla presenza del cibo nella bocca sia alla natura stessa del cibo.
Si è notato che richiedono una più lunga masticazione le sostanze che hanno più scarso contenuto d'acqua, o sapori poco gradevoli, provocando una più abbondante salivazione.
In condizioni normali la secrezione della saliva è regolata da un
meccanismo nervoso riflesso
, che trova la sua origine negli stimoli meccanici della cavità orale e negli stimoli chimici delle papille gustative.
Gli impulsi nervosi, che hanno la loro origine nei recettori, arrivano al bulbo, dove si trovano i
centri della salivazione
: questi, se eccitati, inviano a loro volta impulsi alle ghiandole attraverso il
sistema nervoso parasimpatico
(→ 2).
Le ghiandole salivari sono innervate da fibre del
parasimpatico e del simpatico
che stimolano la secrezione (il primo più intensamente).
Va infine ricordato che lo stimolo alla salivazione, oltre che dalla presenza di alimenti o di sostanze presenti nella bocca, può essere costituito anche da
impressioni visive o olfattive
, da ricordi mnemonici connessi con l'alimentazione.
Le ghiandole salivari hanno l'aspetto di acini d'uva.
Il secreto delle
parotidi
è costituito da
saliva molto fluida
, contenente ptialina;
quello delle
sottolinguali
da
saliva molto vischiosa
, per la presenza di abbondante mucina, mentre manca di ptialina;
quello delle
sottomascellari
da
saliva di tipo misto
, in quanto contiene sia ptialina sia mucina.
Le parotidi versano il loro secreto in prossimità del secondo molare superiore, mediante il
dotto di Stenone
;
le sottolinguali non presentano dotto escretore unico, poiché ciascuna ghiandola è formata da un gruppo di 15-30 ghiandolette, ognuna delle quali presenta un suo proprio dotto;
le sottomascellari si aprono ai lati del frenulo linguale mediante il
dotto sottomascellare di Wharton
.
Gli alimenti masticati e insalivati assumono l'aspetto di un impasto pressoché uniforme che prende il nome di
bolo alimentare
.
A questo stadio, mediante l'atto della
deglutizione
il bolo alimentare passa nella faringe.
Da questo momento il suo cammino attraverso l'apparato digerente non è più governato dalla volontà ma da una serie di
atti riflessi
regolati dal
centro del bulbo
.
La presenza del bolo alimentare nella faringe determina infatti la contrazione dei muscoli di questa e il
sollevamento del velo palatino
che impedisce la comunicazione con le coane, mentre l'
abbassamento dell'epiglottide
, dovuto all'innalzamento nel momento opportuno dell'osso ioide, evita che le particelle solide o liquide possano penetrare nella laringe.
Nello stesso tempo si interrompe l'atto respiratorio (
apnea da deglutizione
) e il bolo penetra nell'esofago.
Qui viene spinto avanti dalla
contrazione muscolare dell'esofago
stesso. Le contrazioni si manifestano in onde lente: perciò, mentre il tratto anteriore è contratto, il seguente viene rilasciato; successivamente è questo a contrarsi, e così via.
Al complesso di contrazioni e rilassamenti si dà il nome di
peristalsi
. Essa, dopo che è iniziata, continua per tutto il tubo digerente.
Il bolo, una volta compiuto il tratto esofageo, passa attraverso il
cardias
e giunge allo stomaco. L'onda peristaltica rallenta infatti in basso, fino al rilasciamento dello sfintere del cardias.
DIGESTIONE GASTRICA
La sua durata varia secondo la qualità e la quantità degli alimenti (i grassi, ad es., ritardando la secrezione dell'acido cloridrico provocano una digestione più lenta): per un pasto medio occorrono circa
tre/quattro ore
durante le quali gli alimenti sono sottoposti ad un'
intensa attività meccanica e chimica
.
Le
contrazioni peristaltiche della muscolatura
, che si manifestano mentre gli alimenti sono presenti nello stomaco, assicurano al medesimo i movimenti necessari al rimescolamento dei cibi e quindi al suo svuotamento.
Tuttavia si possono avere contrazioni molto intense anche quando lo stomaco è vuoto; tali contrazioni coincidono in questo caso con la
sensazione di fame
.
Le pareti dello stomaco sono costituite da più
tuniche sovrapposte
di cui si ricordano la
muscolare e la mucosa
.
La prima è formata da tre diversi strati di fibre: le longitudinali più esterne, le
circolari
disposte nello strato interno.
La seconda tappezza la cavità dello stomaco ed è suddivisa da numerosi solchi in zone dall'aspetto pressoché esagonale, le
aree gastriche
,
nella cui parte mediana più depressa sboccano le
ghiandole gastriche
vari milioni di
ghiandole tubulari
, semplici provviste di rami laterali, si trovano nella mucosa del fondo e sboccano nella cavità gastrica, attraverso altrettanti orifizi visibili sulla sua superficie (→ 3).
Le cellule che costituiscono queste ghiandole, oltre ad alcune caliciformi mucipare, sono di due tipi: le
cellule principali
, situate nella parte più profonda (→ 2), che producono un proenzima, il
pepsinogeno
; quelle
parietali o oxintiche
, situate al di sopra delle prime e distribuite irregolarmente, che elaborano
acido cloridrico
.
Le ghiandole che occupano l'antro pilorico differiscono da quelle del fondo per la tortuosità dei tubi secernenti e la maggiore lunghezza del canale escretore.
Il prodotto della secrezione ghiandolare, ossia il
succo gastrico
, è una mescolanza in proporzioni variabili delle secrezioni di ciascuna delle ghiandole menzionate e di quelle del proprio epitelio mucoso.
I costituenti principali del succo gastrico, che si presenta come un liquido acquoso, sono l'
acido cloridrico
e la pepsina
.
Questa è l'enzima alla cui azione si deve la
demolizione delle grosse molecole proteiche insolubili
in sostanze solubili, i
peptoni
.
La pepsina, come si è detto, viene prodotta sotto forma di un proenzima inattivo, il
pepsinogeno
, che viene attivato poi nella cavità gastrica dall'
acido cloridrico
.
Una volta formatasi, è la pepsina stessa ad attivare altro
pepsinogeno
.
L'
acido cloridrico
, oltre che come attivatore, serve per impartire all'ambiente l'
acidità essenziale
all'azione della pepsina.
Ha inoltre le
proprietà antisettiche
già rilevate dallo Spallanzani quando aveva notato come frammenti di carne, imbevuti nel succo gastrico, resistevano più a lungo alla putrefazione.
Il succo gastrico dei lattanti contiene la
rennina o chimasi o chimosina
, un enzima capace di far
coagulare il latte
, permettendone così una permanenza maggiore nello stomaco, in modo che le proteine in esso contenute possano venire attaccate dalla pepsina.
Nel succo gastrico sono anche presenti in un'azione piuttosto limitata la
lipasi
, la quale però ha la
mucina
, a cui si deve, oltre alla funzione lubrificante, la
protezione della mucosa gastrica
dall'azione dell'acido cloridrico e della pepsina (che potrebbero digerire lo stomaco stesso).
La produzione del succo gastrico non è continua ma ha inizio con l'assunzione del cibo.
In tale stadio essa è dovuta essenzialmente a
meccanismi nervosi
di cui sono responsabili i
nervi vaghi (→ 4)
.
Questi regolano inoltre la secrezione che si può verificare anche alla vista o all'odore del cibo, oppure sotto lo stimolo dell'appetito.
Quando gli alimenti giungono nello stomaco, la secrezione viene stimolata da un ormone, la
gastrina
, liberato dalla
mucosa pilorica
quando questa viene a contatto con il chimo.
Allorché si è compiuta la digestione gastrica e quindi il bolo si è trasformato in una poltiglia biancastra molto fluida, detta
chimo
,
in seguito ad una più intensa peristalsi dell'antro, si inizia lo
svuotamento dello stomaco
e lo
sfintere pilorico
, chiuso tonicamente durante la digestione, si dilata attivamente.
Lo svuotamento dello stomaco procede
lentamente
, a fiotti successivi di chimo, che, appena passati nel
duodeno
, provocano per riflesso la chiusura dello sfintere.
LA DIGESTIONE NELL'INTESTINO TENUE, LA FUNZIONE DELL'INTESTINO CRASSO
La digestione gastrica permette un'incompleta scissione di alcune sostanze proteiche in peptoni, la liquefazione dei grassi, la sterilizzazione, la coagulazione del latte, trasformando il caseinogeno in caseina, nonché un primo parziale assorbimento dei cibi; nell'intestino tenue si compie la
parte fondamentale dell'intera digestione
, in quanto si trovano qui tutti gli enzimi capaci di agire su ogni tipo di alimenti.
Essi provengono, oltre che dalla secrezione intestinale, anche dal
pancreas e dal fegato
i cui prodotti, attraverso propri canali escretori, vengono versati nel
duodeno
.
Già si è detto che la superficie interna dell'intestino tenue ha un aspetto del tutto peculiare per la presenza di duplicature della mucosa stessa e per quella dei
villi intestinali
, la cui densità aumenta progressivamente a mano a mano che ci si allontana dal piloro fino a raggiungere il massimo nell'ileo, ultimo tratto del tenue, dove se ne possono contare sino a 1000 per centimetro quadrato (i villi sono invece assenti nel crasso).
Ogni villo è costituito da uno strato di cellule epiteliali, posto esternamente, e da un tessuto reticolare contenente elementi contrattili, in cui sono presenti
vasi sanguigni, linfatici e fibre nervose
(1. 2).
La mucosa dell'intestino tenue (provvista nel duodeno anche delle
ghiandole di Brunner
, secernenti soprattutto muco) presenta numerose ghiandole tubulari, le
ghiandole di Galeazzi-Lieberkühn
, le quali secernono il
succo enterico
.
Il succo enterico è
alcalino
e contiene non solo una grande quantità di muco, ma soprattutto numerosi enzimi che
completano la demolizione degli alimenti
.
Tra gli enzimi ricordiamo soprattutto l'
enterochinasi
che
attiva il tripsinogeno
(pancreatico) in tripsina, la quale a sua volta catalizza l'attivazione degli altri proenzimi pancreatici, e cioè:
endopeptidasi, esopeptidasi, nucleasi
.
Ricordiamo infine che
enzimi presenti sulle cellule dei villi
scindono i disaccaridi: il lattosio in glucosio e galattosio, il maltosio in due molecole di glucosio, il saccarosio in glucosio e fruttosio.
Come si vede, sono molti i processi che si verificano entro brevissimo tempo e che si intersecano fra loro; per semplificare li descriviamo separatamente.
La mucosa duodenale, in presenza di chimo, secerne anche degli ormoni, tra i quali i principali sono: la
secretina
, che
stimola la secrezione di bicarbonati e acqua nel pancreas
e inibisce la secrezione di gastrina nello stomaco (non serve più!); la
pancreozimina-colecistochinina
, che stimola la secrezione di enzimi nel pancreas, la
contrazione della colecisti
(che riversa la bile nel duodeno) e la motilità intestinale.
Il chimo, oltre a mescolarsi con il succo enterico, si mescola anche con quello
pancreatico
che passa nel duodeno attraverso il
dotto di Wirsung e il dotto accessorio di Santorini
.
La secrezione del pancreas è regolata dai meccanismi nervosi e da due ormoni, la
secretina
(uno dei primi ormoni scoperti e identificati) e la pancreozimina-colecistochinina, prodotti dalla mucosa duodenale, che si libera nell'intestino tenue (→ 4), allorché vi si determina un ambiente acido. Ciò avviene pertanto ogni volta che sia presente il chimo acido proveniente dallo stomaco.
Nel succo pancreatico vi sono tre importanti enzimi, il tripsinogeno (già menzionato), che, attivato a tripsina dall'enterochinasi intestinale, agisce sulle proteine e sui peptoni riducendoli ad
amminoacidi
(in associazione con gli altri enzimi già citati); l'amilasi che trasforma in
disaccaridi
gli amidi non attaccati dalla ptialina; e la lipasi che scinde i grassi neutri nei loro componenti (acidi grassi e glicerina).
L'azione della lipasi è consentita dai
sali biliari
: i grassi neutri si uniscono ai sali biliari costituendo delle
micelle
, cioè delle formazioni con una interfase grasso-acqua nella quale può agire la lipasi pancreatica.
L'azione di tutti questi enzimi viene facilitata dai
movimenti pendolari del tenue
(allungamenti e accorciamenti di tratti intestinali), movimenti che non determinano l'avanzare della massa alimentare, ma continuamente la rimescolano.
Completa il quadro della digestione nell'intestino tenue l'intervento della
bile
secreta continuamente nel
fegato
.
La maggior parte della bile epatica, in ragione di circa 1 litro nelle 24 ore, va ad accumularsi nella
vescicetta biliare
dove si carica del muco secreto dalle ghiandole della vescichetta stessa e dove le sostanze che la compongono e cioè acqua, pigmenti biliari (bilirubina, derivata dalla trasformazione dell'emoglobina),
sali biliari
(sali sodici dell'acido glicolico e dell'acido taurocolico), fermenti e sostanze grasse, subiscono un processo di concentrazione.
Il passaggio della bile nel duodeno attraverso il
coledoco
è invece intermittente e si compie soltanto durante la digestione intestinale.
Come la secrezione pancreatica anche quella biliare è stimolata dalla pancreozimina-colecistochinina duodenale.
La bile
accentua l'azione digestiva del succo pancreatico
, attiva la lipasi pancreatica,
neutralizza l'azione dell'acido cloridrico del chimo
, facilita l'assorbimento intestinale dei grassi determinando le formazioni di micelle attaccabili dalla lipasi pancreatica, eccita la peristalsi intestinale ed esercita un'opera
antisettica
nei confronti della flora intestinale.
Dopo aver subito tutte le profonde modificazioni di cui si è detto, il contenuto intestinale si presenta come un liquido lattiginoso che prende il nome di
chilo
.
La funzione del tenue non si esaurisce con la digestione, ma ne assolve un'altra importantissima: quella dell'assorbimento.
L'
assorbimento
, il cui complesso meccanismo non è regolato soltanto da leggi fisico-chimiche ma anche dall'attività vitale e selettiva dell'epitelio assorbente, avviene, nell'intestino tenue, soprattutto ad opera dei
villi
.
Con movimenti ritmici di allungamento e accorciamento questi determinano il passaggio del chilo nei vasi adibiti al trasporto delle sostanze nutritive attraverso i vasi sanguigni vengono assorbiti gli amminoacidi, i monosaccaridi, la glicerina e le vitamine, l'acqua e i sali minerali, che passano quindi nella
circolazione sanguigna
mediante le vene mesenteriche.
Da queste ha origine la
vena porta
che penetra nel fegato, qui si suddivide in numerosi rami e ne fuoriesce mediante le vene sopraepatiche. Queste si riversano infine nella cava inferiore, portando nella circolazione le sostanze assorbite.
Le sostanze grasse, rappresentate principalmente da acidi grassi, vengono assorbite dai
vasi linfatici
, portate quindi nella
cisterna del Pecquet
e da questa nel dotto toracico che infine si versa nella vena succlavia sinistra, raggiungendo così anch'essa la circolazione sanguigna.
A mano a mano che l'assorbimento procede, il contenuto interstiziale si impoverisce di sostanze nutritive, assume un aspetto più consistente e avanza, sotto la spinta della peristalsi, nell'
intestino crasso
.
In questo tratto intestinale la digestione è
nulla
, poiché da parte della mucosa non vengono prodotti enzimi. Avvengono invece dei
processi fermentativi e putrefattivi
dovuti all'azione della
flora batterica
ivi presente.
Nel crasso avviene inoltre, come si è detto, l'
assorbimento dell'acqua
, per cui la massa intestinale, ulteriormente disidratata e quindi sempre più densa, ricca di sostanze non digerite e di prodotti provenienti dal disfacimento della mucosa intestinale, dà origine alle
feci
.
Scrolla per vedere le altre immagini
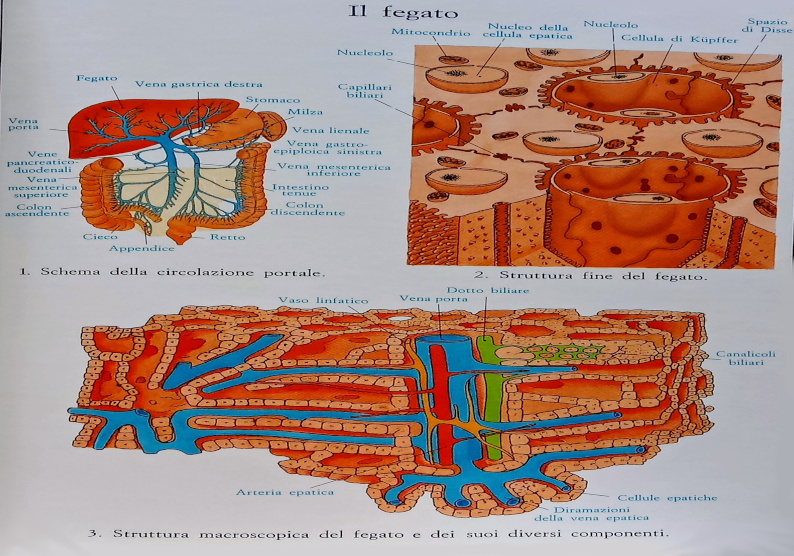
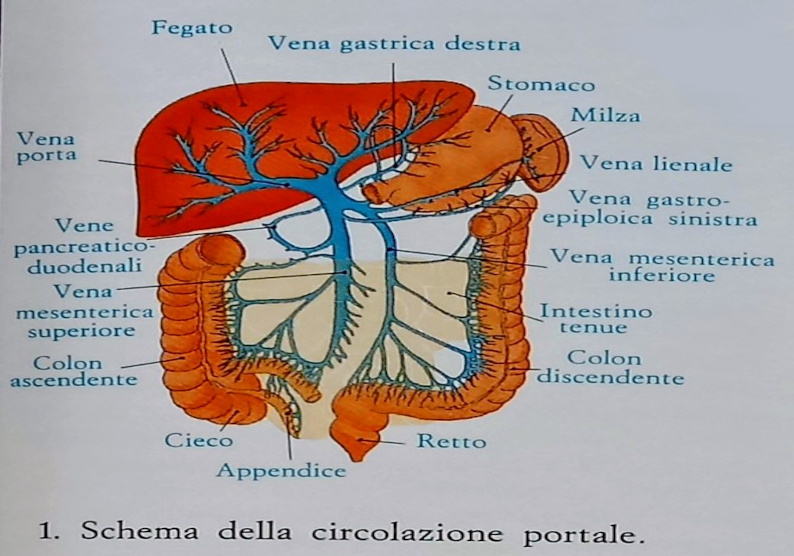
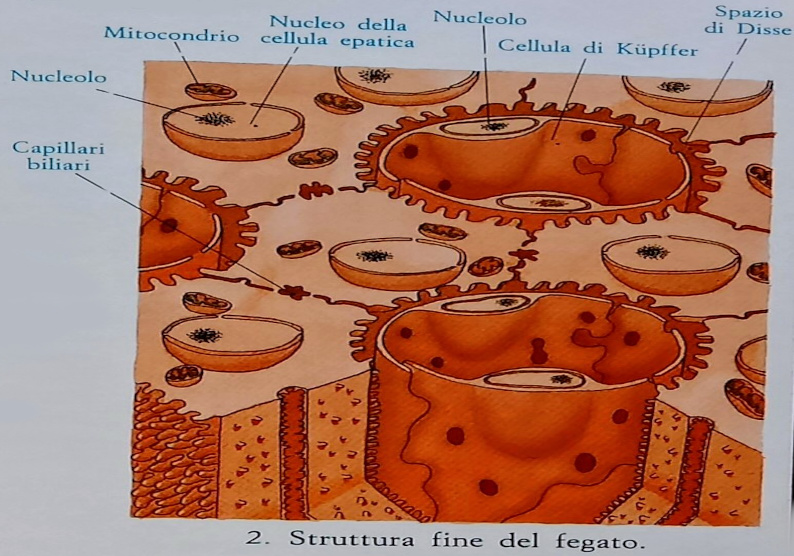
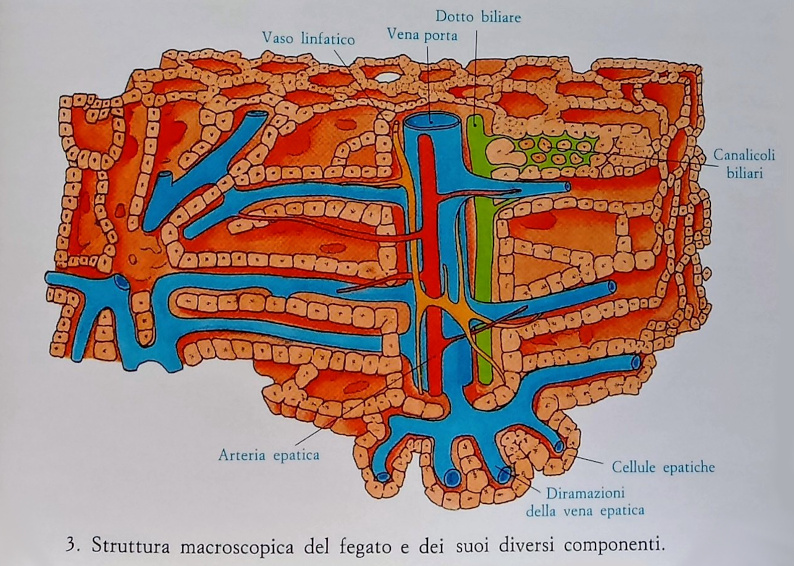
IL FEGATO
L'attività del fegato non si esaurisce nella produzione di bile, questa anzi non è una tra le sue più importanti. Il Fegato
Diamo le principali funzioni del fegato:
- produzione degli amminoacidi essenziali per formare le proteine (citoplasma delle cellule, proteine del plasma, ecc.);
- sintesi delle albumine (importantissime proteine del plasma, ecc.);
- sintesi delle globuline (fattori della coagulazione, enzimi, ecc.);
- sintesi di glicogeno (materiale di riserva) dal glucosio;
- metabolizzazione del glucosio e dei grassi;
- distruzione o inattivazione di sostanze tossiche provenienti dall'esterno o formatesi all'interno dell'organismo;
- sintesi del colesterolo, da cui provengono gli acidi e i sali biliari, e produzione di bilirubina: in pratica, le due più importanti componenti della bile.
IL METABOLISMO
Il
metabolismo
è l'insieme delle
trasformazioni chimiche e biologiche
che si compiono nell'organismo per permettere lo
svolgimento dei processi vitali
.
La continua trasformazione del cibo in materia organica o in sostanza che possa essere bruciata per produrre energia, costituisce l'
assimilazione
o fase
anabolica o costruttiva
del metabolismo;
la successiva degradazione di queste sostanze (escrezione di urina, sudore, emissione di anidride carbonica, ecc.) si dice
fase catabolica
del metabolismo.
Nell'
età giovanile
la fase anabolica prevale sulla catabolica (aumento di peso), mentre nella vecchiaia prevale quella catabolica. Nell'età matura vi è invece
equilibrio
fra le due fasi.
Non tutte le complicatissime reazioni chimiche che costituiscono il metabolismo si sono potute
riprodurre in laboratorio
: ad esempio, solo recentemente si è potuta realizzare (in parte artificialmente) la sintesi delle proteine a catena lunghissima.
Tutte queste reazioni sono dovute all'intervento di innumerevoli
fermenti (enzimi)
(se ne conoscono circa 25.000 e molti altri restano da scoprire), che, a loro volta, possono agire solo in presenza di certe circostanze (catalizzatori, acidità del mezzo, ecc.).
Un normale metabolismo assicura all'organismo umano la costanza
(omeostasi)
delle condizioni fisico-chimiche dei suoi componenti come la composizione chimica dei liquidi interni, la temperatura, ecc.
La quantità minima di energia spesa da un organismo in condizioni base, cioè in
riposo assoluto
, per
mantenere costante la temperatura
, contrarre il cuore, respirare, sintetizzare diverse sostanze chimiche, ecc., si dice
metabolismo basale
.
In condizioni di assoluto riposo il metabolismo corrisponde perciò alla
respirazione cellulare
.
Per determinare tale consumo si ricorre ad una speciale apparecchiatura (→ 3) e, in base al consumo di
ossigeno
e a calcoli che tengono conto dell'età e della
superficie corporea
, si calcola il fabbisogno energetico di un individuo per unità di tempo.
Il metabolismo è influenzato in grandissima parte dall'azione della
tiroide
su tutte le cellule.
BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.